ENIGMI O SFIDE?
Incontro con John Austin di Pontoco
The Last Clockwinder è uno fra i giochi in VR più interessanti e riusciti degli ultimi anni, un'avventura in prima persona dalla forte componente puzzle che si ispira nelle sue meccaniche alle produzioni di Zachtronics. Nel gioco, bisogna costruire dei meccanismi improvvisati per mettere in funzione grossi macchinari e lo si fa utilizzando cloni robotici della protagonista, che si creano registrando le proprie azioni. Movimenti della testa e delle braccia, spostamento del corpo nello spazio, manipolazione di oggetti… tutto quello che il giocatore fa durante la fase di registrazione viene memorizzato e riprodotto dal clone robotico in un loop di alcuni secondi. Possiamo quindi creare svariate copie di noi stessi che collaborano in sequenza per portare a compimento azioni di vario tipo. È una struttura particolarmente azzeccata anche perché quasi completamente irriproducibile con un sistema di controllo tradizionale, ma soprattutto perché garantisce una versatilità di approccio spaventosa, dato che il giocatore può letteralmente modulare i minimi dettagli di movimento dei cloni tramite il suo corpo. Il motore di gioco registra infatti direttamente gli input che il giocatore dà tramite i controller e il visore, utilizzandoli per riprodurre perfettamente le sue azioni. Insomma, è il genere di cose che mi piace vedere in VR, perché davvero ne sfruttano le potenzialità ben oltre un semplice discorso di immersione nel mondo di gioco.
The Last Clockwinder è stato sviluppato dallo studio Pontoco, fondato nel 2015 da John Austin, con cui ho avuto modo di scambiare una lunga chiacchierata. Austin nasce come videogiocatore e inizia a sviluppare la sua sensibilità di designer drogandosi di Pokémon e Golden Sun su Game Boy, ma anche di Chu Chu Rocket su Dreamcast. I germi della sua carriera vengono però piantati da Valve quando rende disponibile l’editor per la creazione di livelli Hammer. Austin, grande consumatore di mod, inizia a cimentarsi con la creazione all’interno di Team Fortress 2: “Ho iniziato quando avevo undici anni e immediatamente incappai in un problema: non finivo mai nulla. Ho poi iniziato a sviluppare un sacco di giochi in Flash che non ho mai finito, ma è stato comunque un periodo in cui ho imparato a fare cose. Ho per esempio imparato a usare il mio primo linguaggio di programmazione, ActionFlash. Però sì, creavo tonnellate di prototipi ma non avevo mai la determinazione, o forse anche il tempo, per mettermi lì a completarli e buttarli fuori.”

Pasticciare tra mod e Flash ha costituito comunque un allenamento utile, nel contesto di un John Austin che sulle prime non era necessariamente convinto di volersi focalizzare sui videogiochi e ha anche sperimento con lo sviluppo di app per il fotoritocco in ambiente Android. Durante gli anni dell’università, però, ha conosciuto le persone con cui avrebbe poi fondato lo studio Pontoco, ma non prima di aver fatto qualche esperienza di lavoro in aziende come Google e Microsoft, in parte per sperimentare, in parte perché la scarsa stabilità della carriera videoludica lo frenava un po’: “Magari volevo fare qualcosa di più normale. Anche perché la programmazione mi piace!
A volte, quando voglio rilassarmi un po', mi prendo qualche giorno di vacanza e lo passo a programmare. Mi diverto così. Per cui, insomma, una carriera "normale" era sicuramente un'opzione sensata e mi sarei trovato bene. Ma mi sono reso conto che avrei preferito di gran lunga lavorare nei videogiochi, anche se c'erano meno garanzie. Preferivo l'idea di fallire nella creazione di videogiochi a quella di avere successo con un lavoro normale. Se non ci avessi neanche provato, sarebbe stato un grosso rimpianto.”
Tra le sue esperienze passate, Austin può vantare anche un periodo da stagista in Funomena, dove ha avuto il piacere di collaborare al folle Wattam, progetto ideato da Keita Takahashi, noto soprattutto come designer di Katamary Damacy. “Ha infilato nel gioco tutto quello che voleva e io ero il suo stagista, lì per soddisfare ogni suo desiderio più folle. Non ero costretto da limiti di produzione, perché ero uno stagista, quindi me ne stavo lì a programmare. Lui diceva roba tipo "Voglio che l'erba danzi" e io lo facevo! Gli altri programmatori avevano effettivamente da lavorare, io stavo lì a fare queste cose folli che Keita chiedeva.”
Un tratto che Austin sembra avere in comune con Takahashi è espresso dal motto dello studio Pontoco, che mira a creare giochi pensati e accessibili: “Tengo molto all'idea di provare a far avvicinare più gente ai videogiochi. Ci sono tanti giochi pensati per gli appassionati, e poi ci sono molti giochi pensati nella direzione opposta, casual, per chi non gioca mai o quasi.

Quello che mi piacerebbe fare è creare giochi che siano divertenti, che piacciano agli appassionati, ma siano anche accessibili a sufficienza per accogliere altre persone. Non ho nulla contro i videogiochi impegnativi, mi va benissimo anche lavorare su un soulslike, per dire, però cercherei di pensarlo in modo che sia piacevole approcciarvisi. Mi piace l'idea di avere come delle rampe di accesso.” Un giocatore hardcore, mi spiega Austin, prende in mano il controller e si mette al lavoro senza problemi, ma chi non ha esperienza con quel genere di gioco può aver bisogno di percorsi d’apprendimento dedicati, per chi è interessato ma non ha dimestichezza e necessita solo di una mano per imparare ad apprezzare l’esperienza offerta.
“È come se fossero dei videogiocatori "potenziali", nascosti, che non hanno modo di avvicinarcisi. I videogiochi sono pieni di esperienze interessanti, confinate dietro a questi muri di abilità richiesta, talvolta impenetrabili. Io voglio conservare il lato dell'abilità, non voglio che i giochi diventino tutti facilissimi, ma voglio fare in modo che la gente possa imparare, invece di andare a sbattere contro un muro gigante. Se non hai mai giocato a un videogioco in vita tua e provi a giocare a Dark Souls, ti schianti contro un muro. Non riuscirai mai a giocarci.” Del resto, i soulslike possono respingere con violenza anche giocatori appassionati e stagionati che non entrano immediatamente in sintonia con le loro dinamiche. “Ed è un peccato, perché quando prendi dimestichezza, sono giochi divertentissimi, e che potrebbero essere amati da molta più gente. Ma questa gente viene respinta.”

L’idea di allargare i confini di accessibilità e interesse tiene conto anche del desiderio di raggiungere quei giocatori “focalizzati” su un genere specifico che non provano mai a uscirne, per esempio chi si limita a comprare tutti gli anni il nuovo Assassin’s Creed e poco altro: “Un po' mi piacerebbe farli uscire dal guscio, spingerli a provare qualcosa di diverso. Intendiamoci, Assassin's Creed va benissimo, da ragazzino ho giocato ai primi due, va bene. Però, ho la sensazione che oggi esista una categoria di giochi in cui si butta dentro un po' di tutto... nel tentativo di assorbire completamente il giocatore, non darti mai un momento di pausa, fare in modo che tu abbia sempre qualcosa da fare. E per carità, è un approccio al game design con un suo senso, ma a me interessa di più creare giochi che abbiano un fine preciso. Il mio gioco ideale dura fra le cinque e le dieci ore. Non mi interessa una storia da 80 ore.” Austin non ama insomma quella sensazione di sentirsi sopraffatti dalla quantità di materiale con cui certi titoli tripla A ti seppelliscono fin da subito e dalla sensazione di stiracchiato e allungato che spesso finiscono per dare. “E non lo intendo per forza in maniera negativa: a molti questa cosa piace! Però non è un'esperienza compatta e rifinita al massimo in termini dei temi di cui parla, delle meccaniche... è più uno spazio in cui esistere. È più diluita, che non è necessariamente una cosa negativa. Però è quello che è. È enorme. C’è dentro una quantità enorme di roba. E lavorare al design di un gioco del genere è un’impresa fuori di testa, non a caso i team sono giganteschi, ben al di là del genere di progetti su cui voglio lavorare io.”
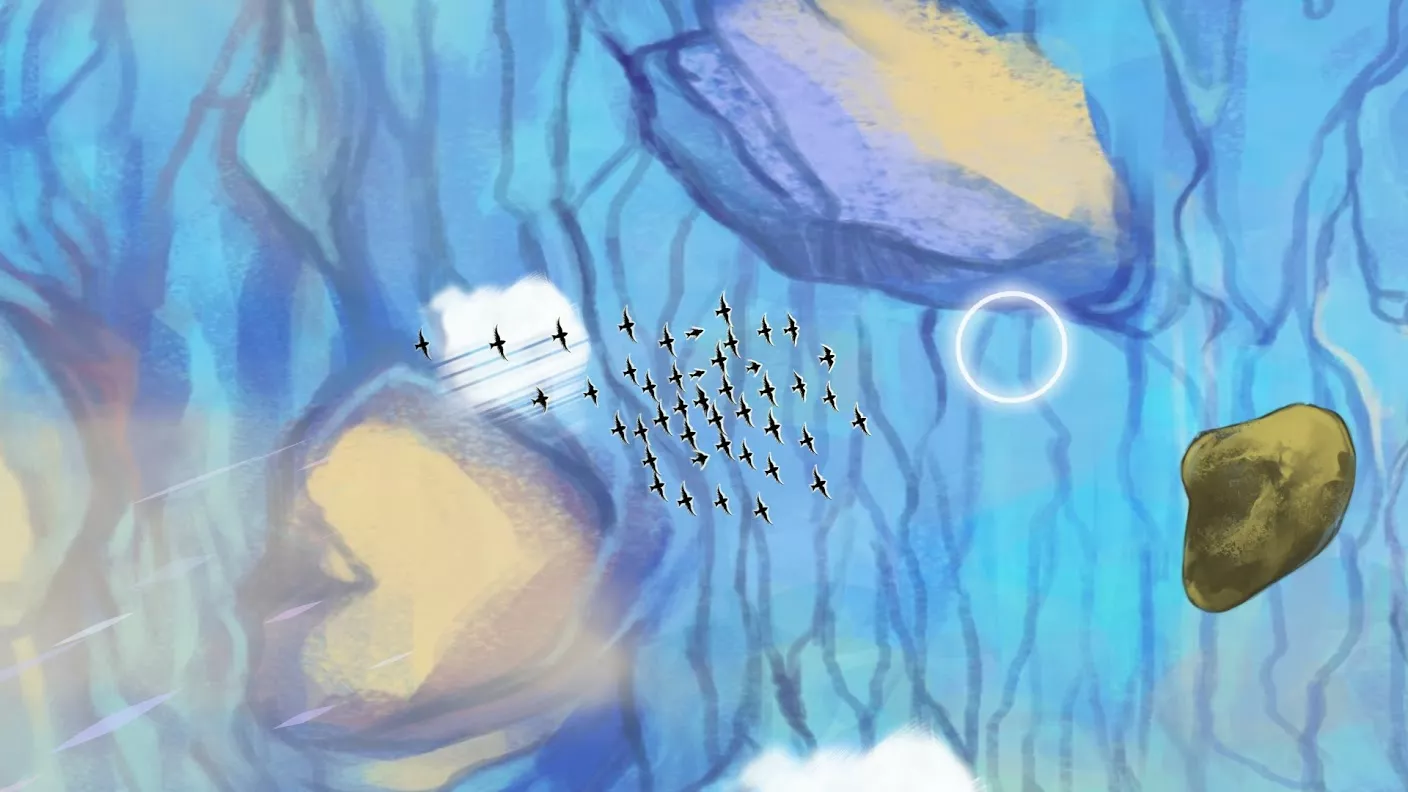
Gathering Sky, primo gioco pubblicato da Pontoco, era focalizzato su un gameplay che mirava a dare un senso di relax, un’esperienza accogliente e adatta a tutti. Del resto, ammette Austin, era nato come risposta diretta al tris magico con cui thatgamecompany si è fatta conoscere oltre un decennio fa: Journey, Flower e Flow: “Sono giochi su cui ho messo mano negli anni dell’università e hanno in qualche modo sbloccato qualcosa nella mia testa.” Grazie al lavoro di Jenova Chen e compagni, Austin ha capito che era possibile creare videogiochi diversi, “qualcosa di coinvolgente ma anche artistico. E con una colonna sonora splendida! Ed è per questo che sono finito a lavorare in Funomena, perché Robin e Martin arrivavano da thatgamecompany, avevano lavorato su Journey. Volevo imparare da loro, capire come lavorassero. Gathering Sky nasce da lì, dal desiderio di fare qualcosa di simile ma con una sua personalità.” Ma Gathering Sky nasce anche dal background da programmatore di Austin, che in quel periodo si era fissato con una tecnica di programmazione chiamata Boids, che simula gli stormi di uccelli: “Ci stavo pasticciando e decisi di sviluppare un gioco in cui si controlla uno stormo di uccelli con l’interfaccia multitouch dei dispositivi mobili. Credo che sia il gioco più artistico su cui io abbia lavorato ed è un genere di cosa che ha un posto speciale nel mio cuore. Però, insomma, ho uno studio da mandare avanti e mi rendo conto che anche quello è un tipo di gioco che sa essere impenetrabile, seppur in modo diverso. Magari è più una cosa da fare a fine carriera! Oggi come oggi voglio creare giochi che risultino accessibili a più gente.”
L’idea, mi spiega, è di prendere cose che la gente pensa di capire, con cui ha familiarità, e usarle come cavallo di Troia per offrire esperienze particolari e artistiche. È appunto il caso di The Last Clockwinder, che prende l’immediata comprensibilità dell’interazione nella realtà virtuale, la applica a una meccanica interessante e usa il tutto come punto di partenza per raccontare una storia ricercata e diversa dal solito. “Abbiamo una meccanica che ricorda molto quelle dei giochi dedicati alle fabbriche, basati sull’automazione, e il primo istinto sarebbe di raccontare una storia a base di distopia steampunk, sul capitalismo, o qualcosa del genere. Ma io volevo fare altro. Volevo un’esperienza dolce, calda, l’esatto opposto delle sensazioni che ti genera una fabbrica. Ecco, anche per i nostri prossimi giochi, stiamo cercando di ragionare in questi termini: prendere generi esistenti e approcciarli in maniera diversa dal solito, sovvertirli.”
The Last Clockwinder, tra l’altro, è un gioco sostanzialmente possibile solo in VR, perché le sue meccaniche non sarebbero riproducibili con un sistema di controllo tradizionale, se non in maniera estremamente limitata. Proprio per questo, è sorprendente scoprire che non sia nato come progetto per la realtà virtuale: “Io mi ritengo molto pragmatico e non amo seguire i trend. La VR mi piace molto ma non mi sarei messo a sviluppare un gioco partendo dal desiderio di fare qualcosa in VR e andando poi alla ricerca dell’idea giusta. Anzi, abbiamo fatto esattamente il contrario e all’inizio non eravamo convinti di voler lavorare con la realtà virtuale, perché inseguire i trend è sempre rischioso. Però, mano a mano ci siamo resi conto che la versione migliore possibile di questo gioco era quella in VR. Esiste un prototipo giocabile in maniera tradizionale e abbiamo ragionato a lungo sulla possibilità di proporre le due versioni, ma è terribile. Poterti vedere in realtà virtuale ed eseguire quei piccoli movimenti lo rende un gioco completamente diverso.”
Scherzando, dico a Austin che Gathering Sky e The Last Clockwinder, con la loro poetica leggera ed emotiva, non sono il genere di cose che ti aspetteresti da un designer con un background da ingegnere informatico. E in realtà lui concorda: “Cerco in maniera molto aggressiva di non fare una roba di quel tipo, di fare invece il genere di gioco che amo e che mi rende felice. Il bello di un Journey è che è interamente basato sulle emozioni, che manipola le tue emozioni in maniera molto sottile, con la musica, l’estetica, il ritmo… e vorrei che più giochi facessero quel genere di cose. Anche i giochi “tradizionali”! Immaginati uno sparatutto che sfrutta quelle tecniche per fare qualcosa di interessante e nuovo… e invece continuiamo a vedere sempre le stesse cose basilari.” Austin ama programmare ma riesce ad astrarsi da questa sua passione e ritiene che il codice debba essere il mezzo, non il fine. E adora anzi l’intersezione delle discipline, “il poter dirigere gli scrittori, parlare col compositore, avere sempre qualcosa di nuovo di cui occuparmi per manipolare il gioco.” Ed è una cosa che comunque filtra attraverso il suo punto di vista da ingegnere: “Lavorando su The Last Clockwinder, ho cercato di imparare le basi del disegno, per poter comunicare meglio con la nostra art director. Ma l’ho fatto con un approccio schematico, da architetto: mi sono appassionato alla prospettiva, alle linee, a un approccio artistico molto preciso. Ma la nostra art director ragiona in maniera completamente opposta. Praticamente va in trance e produce materiale spettacolare, in maniera intuitiva. Per me è come un enigma da risolvere. Vedo tutto in termini di obiettivi, di pianificazione, dove tutto ha uno scopo finale e non si procede mai a braccio.”

Un tema molto caro a John Austin, che vi ha anche dedicato un intervento alla Game Developers Conference, è quello della contrapposizione fra puzzle e sfide. Secondo la sua visione delle cose, i puzzle sono un qualcosa di limitato, che offre una soluzione singola, su cui tendi a bloccarti e che quando riesci a risolverli ti regalano quel momento “eureka!” Le sfide permettono invece soluzioni multiple, creative, lasciano libertà di approccio. Là dove i puzzle game hanno obiettivi da raggiungere, i giochi basati sulle sfide si chiedono quanto sei stato bravo a risolvere il problema. E questo cambia tutto, perché aggiungere una misurazione di quanto è stato bravo il giocatore crea una dinamica mentale diversa, spinge molto di più a ragionare e ipotizzare soluzioni, magari anche impossibili. “Le misurazioni non sono un’aggiunta al sistema, ampliano il sistema.”
The Last Clockwinder, in quest’ottica, è interessante, perché ha delle meccaniche molto libere e versatili, che ti danno la sensazione di poter fare quello che vuoi. Ma in realtà è poi molto preciso e bilanciato in ciò che ti permette effettivamente di fare ed è pieno di piccole soluzioni pensate per limare errori e imprecisioni del giocatore: i meccanismi sono pieni di tubi che aspirano i componenti “arrotondando” la precisione richiesta; il sistema di controllo implementa lo “snapping” per afferrare gli oggetti al volo; quando si tagliano i rami delle piante, i tagli sono sempre uguali, così come lo sono i nuovi rami. È insomma pieno di piccole soluzioni che da un lato armonizzano l’esperienza di gioco e dall’altro la rendono più schematica, precisa e misurabile, per esempio nella scelta di limitare la durata dei cloni robotici a multipli a base due. “Fondamentalmente,” mi ha spiegato Austin, “dietro le quinte è un gioco di Zachtronics ed è pieno di soluzioni specifiche che noti solo se sei un giocatore super approfondito e dedito all’ottimizzazione.”
Nel progettare il gioco, Pontoco ha anche usato molto la tecnica della piramide invertita, amata molto anche da Unknown Worlds Entertainment, lo studio di sviluppo di Subnautica. “In Subnautica”, mi ha detto Austin, “la piramide invertita è abbastanza letterale, perché parti dalla superficie dell’oceano e vuoi raggiungere il fondale: finché sei in cima, hai la sensazione di poter andare dove vuoi, ma dovunque tu vada, quando inizi a scendere, vieni attirato verso la punta della piramide. Così ti dà la sensazione di avere il controllo e potere decisionale, ma in realtà è piuttosto lineare.” Austin ha provato a riprodurre quel metodo in The Last Clockwinder, dando al giocatore tante opzioni e tanta libertà, ma strutturando comunque il gioco in modo che fosse inevitabile finire nel punto corretto. “Quando guardi la gente che gioca, nella sostanza ci sono poche differenze in quello che fanno.”

Un elemento che differenzia in maniera netta i giocatori è la separazione fra chi vuole seguire la storia e chi vuole ottimizzare i sistemi di gioco. “Io,” ha ammesso Austin, “sono decisamente un giocatore del primo tipo, mi piace giocare in quel modo. La mia compagna si mette lì e prova a rompere il gioco, si arrampica sui muri, cerca i trucchi, vuole ottimizzare. Io lascio che il designer mi dica cosa fare, mi fido di lui e lascio che mi insegni cosa devo fare, dove devo andare.” Ma esistono ottimizzatori folli, capaci di trascorrere ore e ore su un singolo enigma al fine di trovare la soluzione più efficiente possibile. E fra gli aspetti interessanti di The Last Clockwinder c’è il modo in cui il team è riuscito a bilanciare l’esperienza in modo da assecondare entrambe le tipologie di utenti. All’interno del gioco c’è una sorta di sistema economico per certi versi simile a quelli che si trovano in ambito social. I meccanismi che si costruiscono e attivano risolvendo gli enigmi vanno a produrre in catena di montaggio delle risorse necessarie per sbloccare le fasi successive dell’avventura. E quindi, se costruisci un macchinario lento e poco efficiente, potresti dover aspettare che le risorse si accumulino, un po’ come in quei giochi per smartphone che ti costringono a smettere di giocare per qualche ora (o a pagare per proseguire immediatamente). Secondo Austin, però, il sistema di risorse contenuto in The Last Clockwinder è costruito in modo da adattarsi allo stile di gioco: “Se sei un giocatore focalizzato sulla storia, che magari risolve gli enigmi lentamente ma non ci torna poi sopra per ottimizzare, impieghi molto tempo sui puzzle e nel frattempo le risorse si accumulano lentamente. Se sei un giocatore più rapido e costruisci macchine efficienti, accumuli risorse più in fretta ma risolvi i puzzle più in fretta. E quindi il risultato è lo stesso: hai bene o male lo stesso numero di risorse quando completi un puzzle.” Le due componenti dell’avventura si compensano a vicenda e il bilanciamento delle risorse regge. “Certo,” ha aggiunto, “è meglio non dirlo agli ottimizzatori, perché rompe un po’ la loro illusione di creare più risorse.”

Il punto era evitare che i giocatori più bravi completassero il gioco a velocità supersonica e i meno bravi ci mettessero fin troppo. Perché nessuno dei due sarebbe stato soddisfatto. “In questo senso, il gioco è simile ai giochi di Zachtronics: se sei un giocatore molto abile, puoi ottimizzare a livelli incredibili, ma se sei un giocatore meno esperto, non hai bisogno di arrivare a quel punto. E,” aggiunge Austin, senza nascondere quanto vada fiero di questo risultato, “si torna al discorso sulle barriere d'ingresso che facevamo prima: The Last Clockwinder, almeno secondo me, è un gioco accessibile a tutti. Potrei farlo provare a qualcuno che non ha mai toccato un videogioco e, idealmente, dovrebbe essere in grado di giocarci e arrivare fino in fondo senza consultare guide o scervellarsi su un enigma. Allo stesso tempo, supporta i giocatori di alto livello, ha tutto quel che serve a chi vuole approfondire.”
E questo approccio ha funzionato? The Last Clockwinder è andato bene, ha soddisfatto le aspettative di Pontoco? La domanda mi sembra interessante anche e soprattutto perché si tratta di un gioco in VR, un segmento attorno al quale si sente dire ogni giorno tutto e il contrario di tutto ma per molti l’entusiasmo sembra essere sfumato e gli oracoli prevedono morte e distruzione. “Per noi ha funzionato. Va detto che abbiamo ricevuto il Game of the Year di Meta, che sicuramente ha aiutato, e non è che questa cosa la si possa usare come strategia. Però in generale penso che sia un settore in cui è possibile fare bene. Una cosa bella della VR è che hai un pubblico dedicato e che ha fame di contenuti. Non è che ci siano poi così tanti bei giochi in VR, quindi, se riesci a pubblicare qualcosa di qualità, può avere successo.” Ciò non toglie, mi spiega Austin, che sviluppare in VR sia una bella sfida, e non solo per la situazione di mercato. Intanto, è ovvio, si tratta di un ambito tutto sommato ancora abbastanza nuovo, nel quale c’è ancora molto da scoprire e da esplorare sul piano delle interazioni. Ma non è solo una di desgin: “Non è semplice neanche programmare, può richiedere il doppio del tempo. Per esempio, in un gioco tradizionale, quando raccogli un oggetto, puoi farlo scomparire, o far partire un’animazione, e poi sta nell’inventario. In VR, ogni oggetto deve essere qualcosa di fisico e quando lo raccogli deve rispondere in maniera naturale. E se vuoi metterlo nella borsa, devi metterlo nella borsa. Ci sono tutte queste interazioni fisiche che richiedono molto più lavoro. Anche perché se le semplifichi e lo rendi magari solo punta e clicca, poi il giocatore ha la sensazione che manchi qualcosa.” Austin non nega che anche in VR ci sia spazio per provare a fare cose più astratte senza rimanere ancorati alla corrispondenza totale fra virtuale e reale, ma per lui i controller basati sul movimento e la libertà che ti danno sono fondamentali, per certi versi anche più del visore stesso: “In termini di game design, dei controller che ti permettono di afferrare cose, lanciarle… Sono qualcosa di incredibile. Il visore ti dà l’immersione, e sicuramente ce n’è bisogno. Però, se ci pensi, nei primi tempi della VR, quando si giocava ai prototipi usando un controller Xbox, mancava qualcosa. Non era l’esperienza completa… servono entrambe le cose.”

Ma come mai è così complesso sviluppare un gioco in VR? Soprattutto, ritiene Austin, perché come detto l’interazione richiede molto più lavoro. Sul piano visivo, invece… “è complicato. Il discorso è anche che in VR, ogni oggetto che puoi raccogliere, puoi anche portartelo vicino agli occhi. E puoi spostarti in giro e piazzarti con la faccia attaccata al muro. In giochi di altro tipo, invece, hai magari una telecamera fissa. In Hades, non devi creare asset che facciano bella figura anche se li guardi da vicino. L’importante è che siano OK dalla distanza. Ma in VR ogni cosa deve essere bella anche se te la piazzi in faccia. Ed è un sacco di lavoro pure quello.” Tant’è che, mi spiega, in Pontoco stanno ragionando molto su come gestire la telecamera del loro prossimo gioco e, nel caso decidessero di lavorare ancora una volta in VR, stanno cercando possibili soluzioni per limare questo e altri problemi. “Anche la fotografia, in VR, è molto complessa, perché non puoi controllare le inquadrature. Per il prossimo gioco stiamo provando a ragionare su come sia possibile farlo almeno un po’, ragionare su composizione e fotografia.”
In conclusione d’intervista, chiedo come mio solito se ci sia un qualche gioco recente che Austin abbia molto amato, e per quale motivo. Lui mi menziona Disco Elysium, cosa che ci porta in realtà a chiacchierare ancora un po’. “Ha un senso di malinconia che apprezzo molto e che credo si percepisca un po' anche in The Last Clockwinder. Mi piace proprio quella tristezza un po' bizzarra, che non è proprio completamente triste, è agrodolce. Sono ricordi, reminiscenze, desideri per qualcosa di sfuggente e perduto... mi piace molto e Disco Elysium lo esprime benissimo. Non è un mondo strettamente triste, è anche molto buffo, ma malinconico, e un po' lugubre, lo adoro. E la scrittura è fantastica, fuori di testa. E la grafica. È tutto clamoroso e mi ha ispirato molto. Ed è pure un gioco di successo! Non è una cosetta piccola, di culto, relegata al filone dei giochi artistici. Fa cose davvero artistiche e interessanti ma anche di successo.” E in effetti, quel tono malinconico di cui parla è presente anche in The Last Clockwinder, un gioco che racconta una storia generazionale, su madri e figlie… “E quello è un altro aspetto importante: non mi interessa creare storie incentrate su uomini bianchi grossi e burberi. È un territorio che è già stato esplorato fino allo sfinimento. Voglio ideare cose più interessanti, c'è talmente tanto potenziale da sfruttare per storie differenti, bisogna provare a cambiare un po' tematiche, fosse anche solo per provare a proporre qualcosa che risulti nuovo.”
Secondo Austin è importante provare a raccontare storie migliori e di tipo differente perché costituiscono un modo per coinvolgere maggiormente i giocatori e possono aprire opportunità inedite sul fronte del pubblico a cui ci si può rivolgere. Certo, parlando di narrazione, mi viene da pensare a quel che dicono le statistiche, al fatto che i giochi mediamente vengono completati da meno della metà dei loro giocatori, a prescindere da quanto durino. The Last Clockwinder, mi conferma Austin, è assolutamente nella media del settore: fra il 30% e il 40% dei suoi giocatori l’ha portato a termine. Di contro, però, può vantare una statistica da record nella lunghezza della prima sessione: “La gente prova il gioco e ci sta immediatamente attaccata per ore. Praticamente giocano fino a prosciugare la batteria del visore. Ed è una cosa abbastanza unica che caratterizza il nostro gioco. Questo mi fa pensare a un aspetto del game design secondo me molto importante, che è la gestione del ritmo. Stare cioè attenti a com'è l'esperienza del giocatore in ogni momento del gioco. Cercare di mantenere l'equilibrio giusto fra enigmi e narrazione. E introdurre delle pause.” Ed è anche per questo motivo che The Last Clockwinder include quelle parti ambientate sul balcone della casa: spezzare il ritmo del gameplay con delle fasi statiche e fortemente incentrate sul racconto. “Perché altrimenti ti ritrovi con quei puzzle game che ti seppelliscono di un enigma dopo l'altro e finisci per essere un po' sopraffatto. È il concetto del game design al porridge: il porridge può anche essere buonissimo, ma dopo un po' è sempre la stessa roba. E gira e rigira, tende ad essere un po' piatto. È un tema su cui ragiono tantissimo. E penso che avere avuto in testa questa cosa sia parte del motivo per cui abbiamo quella statistica così fuori dal normale per le prime sessioni di gioco.”

Austin ammette candidamente che parte dell'ispirazione per gli enigmi di The Last Clockwinder arriva dalla sequenza de L'apprendista stregone nel film Fantasia.
Complessivamente, comunque, Austin si dice soddisfatto della percentuale di persone che arrivano in fondo al suo gioco e del fatto che i giocatori sembrino apprezzare la storia: “È sempre un aspetto stressante, da game designer. Passi tutto quel tempo a lavorare su un racconto intimo, a cui tieni molto, e poi non sai se i giocatori ci entreranno in sintonia. Nei playtest sembrava funzionare ma insomma, fino a che non pubblichi il gioco non lo sai mai. Ti chiedi se magari verrà apprezzato il gameplay ma troveranno la storia orribile. Quel genere di timori.” Ovviamente, esistono anche i giocatori a cui non interessa minimamente seguire il racconto, che puntano solo al gameplay. Ma convincere chi invece ci tiene ad avere un bel racconto costituisce una bella soddisfazione: “E penso davvero che sia importante avere belle storie. Gioco a tante cose in cui la storia finisce per peggiorare l’esperienza. Giochi potenzialmente bellissimi in cui la storia è solo una distrazione. Ed è brutto. Se la storia deve essere pessima, allora preferirei che non ci fosse.” E non è per forza una questione di voler raccontare grandi temi o approfondimenti letterari sofisticati: “Secondo me spesso si sottovaluta un fatto: anche la storia più semplice e tradizionale, il più classico del viaggio dell’eroe, si può scrivere molto male, oppure può essere di grande intrattenimento se si fa un buon lavoro.”
E in questo senso talvolta si sottovaluta l’impatto che può avere anche solo la chiacchiera generica fra i personaggi durante l’azione, il “banter”. Sono componenti che possono sembrare insignificanti e invece possono fare molto. E anche in quello si vede la differenza fra chi ingaggia un bravo scrittore e chi sceglie di tirare via quest’aspetto. “Talvolta con ci si ferma a chiedersi, per esempio, se quella che stai scrivendo sia una cosa che il personaggio direbbe in quella situazione. O se quella battuta serva effettivamente a qualcosa. C’è un concetto generale nella scrittura, soprattutto in quella per il cinema, che ogni scena, ogni dialogo, ogni elemento dovrebbe portare del cambiamento. Non deve andare sempre nella stessa direzione, ma al termine di una scena dovrebbe essere avvenuto un cambiamento: magari il personaggio ha cambiato opinione, o lo spettatore ha cambiato idea o ha capito qualcosa di nuovo. Invece, in molti giochi i dialoghi sono solo chiacchiera senza significato. Si può fare di meglio e non è difficile. O meglio, è difficile, ma alla fine basta semplicemente ingaggiare uno scrittore bravo. E non è che siano poi così costosi!”

Pubblicato il: 18/02/2025
Il tuo supporto serve per fare in modo che il sito resti senza pubblicità e garantisca un compenso etico ai collaboratori
FinalRound.it © 2022
RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128